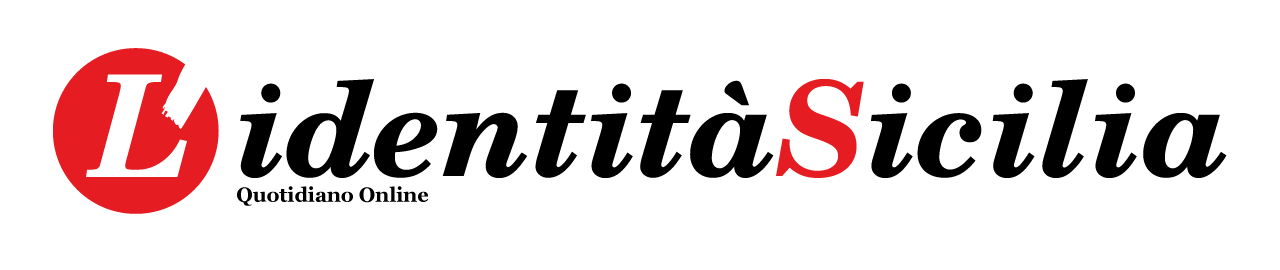L’inchiesta che scuote la Sicilia, ma il sistema è sempre lo stesso e così fa affogare la regione
di PIERO MESSINA
Renato Schifani non parla. O meglio, tace rumorosamente. E nel suo silenzio c’è tutto: l’imbarazzo, la paura. E forse anche il sollievo. Forse è giunto il momento di tagliare il cordone con alleati troppo ingombranti? È a Bruxelles il presidente, dove tenta – non senza solide ragioni – di convincere l’Europa che la Sicilia sa gestire i rifiuti. Ma a Palermo la spazzatura vera — quella morale e politica — gli esplode sotto i piedi.
La bomba l’ha sganciata la Procura di Palermo: un’inchiesta che scoperchia il verminaio della Regione, dove la Democrazia Cristiana del redivivo Totò Cuffaro si comporta come se nulla fosse cambiato dai tempi dei cannoli. Solo che oggi quel metodo non è più leggenda del passato: è cronaca, intercettata, verbalizzata, firmata dai carabinieri del Ros.
Sarebbe facile – e anche un po’ ipocrita – esercitare l’ignobile arte della crocifissione politica, additando l’ex presidente come unico responsabile e carnefice dell’isola. Cuffaro, già condannato a sette anni per favoreggiamento alla mafia, dopo la “redenzione africana” e il nuovo abito da padre nobile del centro moderato, è tornato esattamente dov’era: al centro del potere. E chiaramente non ha potuto farlo da solo. Ma stavolta non da presidente, ma da arbitro dell’agone politico. E in fondo non è neanche tutta colpa sua. Tanti siciliani lo amano, lo vogliono, lo venerano. Amen. Fin qui i fatti. Ma la politica, ancora una volta, non se ne accorge o finge di non farlo.
Oggi come venti anni fa, la cornice giudiziaria restringe la visuale sul vero cuore del potere: la sanità. Da lì poi partono intersezioni e ramificazioni sull’intero sistema siciliano. E pur senza alcun incarico ufficiale, l’ex governatore — almeno secondo gli inquirenti — gestiva nomine e concorsi come un direttore d’orchestra: un posto all’Asp di Siracusa per un amico, un commissario “fidato” a Palermo, un concorso pilotato per gli operatori socio-sanitari di Villa Sofia-Cervello, dove perfino le tracce degli esami circolavano in anteprima. Tutto “a disposizione di Totò”. Così dicono i magistrati.
Chi non stava al gioco veniva messo nel mirino. E se non bastavano le pressioni, arrivavano le telefonate e gli incontri “amichevoli”: «Ti scasso la minchia su tutto», diceva Cuffaro all’assessore Luca Sammartino, reo di voler rimuovere un suo fedelissimo da un consorzio di bonifica.
Ma alla fine, come in ogni fiaba siciliana, il vecchio vince sul giovane. La legge si riscrive, il direttore resta, e il potere torna sempre nelle stesse mani. “Chistu è u succu rù discursu”, diceva Totò, con la saggezza di chi il sistema lo conosce a memoria. Il succo del discorso, appunto, erano gli appalti: 280 milioni di euro per opere pubbliche e un elenco di imprese “disponibili” da favorire.
Cuffaro consegnava i nomi come un notaio, con tono paterno, quasi liturgico: “Questa è una di quelle cose che devi fare”. Con la leggerezza del “così fan tutti”. Certo, è tutto da dimostrare.
Per il cittadino comune, la Sicilia appare amministrata non da una giunta, ma da un comitato d’affari. E non è neanche importante stabilire se tutto ciò sia lecito o meno. È il costume politico ad essere marcio: un potere che si autoperpetua, tra indifferenza e consenso.
Nel frattempo, il presidente Schifani osserva da lontano. Legge i giornali, medita sul suo stato WhatsApp — “Vai avanti anche quando sembra inutile” — e si chiede se valga la pena guidare “una terra irredimibile”. I suoi alleati si scannano, la coalizione è a pezzi, Forza Italia e Fratelli d’Italia si guardano in cagnesco, e la manovra da un miliardo rischia di saltare. Nei mesi precedenti le leggi finanziare sono state affondate a colpi di voto segreto. Nei bar di Palermo e nei mercati di Catania, intanto, l’indignazione dura quanto un caffè. Poi si cambia discorso.
È questa la forza del sistema: la rassegnazione popolare. E l’inconfessabile desiderio di poter accedere a quel sistema: per un posto da precario, per una visita medica, per un microappalto utile per tirare a campare. Ai siciliani bastano le briciole.
Nella Democrazia Cristiana di Cuffaro cala il gelo. Tutti “sorpresi, sgomenti, smarriti”. Tradotto: nessuno sapeva nulla. Eppure la rete era ovunque: nei bandi, nelle nomine, persino nella Protezione Civile, dove avrebbe cercato di “convincere” il capo Salvo Cocina con metodi, diciamo così, poco ortodossi. Dentro il partito si alza anche qualche voce di rottura. Sono in molti a non voler credere, a non accettare che la nuova Dc sia solo la fotocopia sbiadita della peggiore politica del passato.
Quando le cose si mettono male, Totò confida agli amici che, se arrivano i guai, “magari mi fermo qualche mese in Burundi”. Non proprio un dettaglio trascurabile: tanto che i magistrati chiedono gli arresti domiciliari per pericolo di fuga.
Dal centrodestra, neanche un sussurro. Schifani si rifugia nel burocratese: “Piena fiducia nella magistratura”. Dal centrosinistra, la solita indignazione intermittente: Pd e M5S promettono mozioni di sfiducia, raccolte firme e titoli sui giornali. Ma la postura è più per mettersi in mostra che per cambiare qualcosa.
Intanto la Sicilia affoga. Non solo nella corruzione, ma letteralmente: senz’acqua, senza servizi, senza credibilità. La sanità è al collasso, le liste d’attesa infinite, i pazienti oncologici dimenticati.E mentre gli ospedali si svuotano e per curarsi si fugge, la politica discute su dove “mettere” il prossimo direttore generale e in quota a chi. Così, il motto di Schifani, “vai avanti anche quando sembra inutile”, suona come un epitaffio. Perché in questa terra, dove gli scandali passano e i protagonisti restano sempre gli stessi, andare avanti è davvero inutile. E infine c’è la questione del Ponte sullo Stretto. Dopo la mancata bollinatura della Corte dei conti, si scopre che nell’inchiesta si parlava anche di questo: c’è traccia nelle oltre 250 pagine redatte dagli investigatori. Omissis a raffica. Roba da far tremare i polsi sul futuro che verrà. A Roma ne dovranno tenere conto. O forse — come direbbe Totò — “u succu rù discursu” è proprio questo.