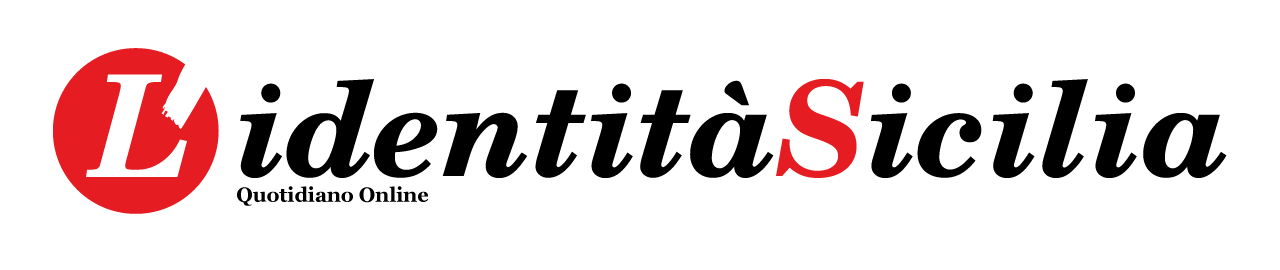Una storia di mafia e amore
di PASQUALE HAMEL
Umberto Eco sosteneva che la differenza tra la saggistica e la narrativa consiste nel fatto che la prima intende dimostrare una “tesi” cercando di risolvere certi problemi, mentre la seconda evidenzia le contraddizioni della vita mantenendo una forte carica di ambiguità e, riferendosi alle proprie opere, aggiungeva che “se la saggistica lavora verso la risposta la narrativa lavora in direzione della domanda e dunque si possono rivelare complementari.
Parto proprio da quest’assunto del noto semiologo italiano per parlare di Una storia di mafia e di amore, Zolfo editore, originale opera letteraria frutto della penna di uno storico affermato qual è Salvatore Lupo. Originale nell’impianto, in gran parte si sviluppa come romanzo epistolare mentre, per il resto, si tratta di stralci di un dialogo fra la vera protagonista e il suo diario, tutti ordinati e articolati in una equilibrata composizione, con l’aggiunta di una chicca, quattro documenti originali tratti dagli archivi.
Così ne viene fuori una costruzione letteraria che non ha solo il pregio di avvincere il lettore ma anche quello di scartare quel superfluo, sul quale sovente giocano i narratori di professione, senza con questo nuocere alla qualità del racconto. Quest’opera si potrebbe anche ascrivere nel novero dei romanzi storici, come peraltro afferma lo stesso autore e in considerazione del fatto che un pezzo di storia ne costituisce il fil rouge e lo stesso contenuto, ma questa categorizzazione ci appare, forse, poco puntuale perché, se la storia costituisce l’ordito nel quale si muove il racconto.
Più puntuale, però, ci appare la identificazione nella categoria del romanzo didascalico che, come sappiamo, è soprattutto una narrazione in cui manca la piena adesione alla propria essenza di romanzo.
Entrando nel merito dell’opera, balza evidente che il racconto di Lupo, e non casuale il fatto che risuoni in qualche passaggio il richiamo a Giovanni Verga, è una storia di vinti, anche se non rassegnati alla sconfitta, che si confrontano con la forza della brutalità mafiosa ma, anche con un potere pubblico autoreferenziale, al punto che preferisce non vedere.
Un potere pubblico che troppo spesso indulge agli “aggiustamenti” nel tentativo, non solo di coprire corruzioni e connivenze, ma perfino banali errori di valutazione fe che per questo finisce per favorire gli interessi e disegni criminali. Per tessere la trama del racconto, l’autore attinge a piene mani alla storia, ai documenti che gli hanno permesso, in anni di faticose ricerche, di comprendere la filosofia e il modo di agire di una Mafia che nel pensiero dominante del tempo costituiva “un argomento troppo delicato per darlo liberamente in pasto al pubblico, e troppo volgare per considerarlo degno di studi storici.”
Sul piano formale si può dare atto all’autore di avere mirabilmente tracciato il profilo dei protagonisti, a cominciare da quello di Elena Fiorito, felice frutto di un’invenzione letteraria, e di Ermanno Sangiorgi, personaggio realmente esistito fra i pochi che hanno avuto del “sodalizio criminoso” detto mafia – delle sue trame e delle sue connivenze – una idea abbastanza chiara.