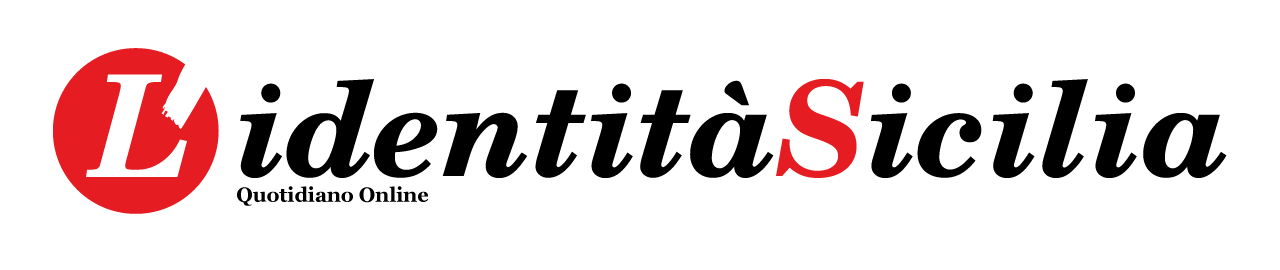I SICANI – Quando la mafia si chiamò mafia
di PASQUALE HAMEL
Il termine mafia irrompe nel linguaggio corrente a partire dall’anno 1863 – secondo il noto antropologo Giuseppe Pitré, prima di allora il termine mafia era praticamente sconosciuto – quando a Palermo, precisamente al teatro Sant’Anna, andò in scena un’opera teatrale che registrò un grande successo di pubblico. Ci si riferisce a “I mafiusi de la vicaria”, un dramma scritto da un capocomico, tale Giuseppe Rizzotto, con la consulenza del maestro elementare Gaspare Mosca, che non aveva nulla a che fare con l’omonimo politologo Gaetano. Si trattava di un’opera dialettale, ambientata nella grande prigione cittadina, frutto di un assemblaggio, con relativa rielaborazione, di singole scene, o quadri, che già erano stati rappresentati “nelle strade o nei teatrini popolari o ultrapopolari di Palermo” e che ora, grazie alla sapiente consulenza del maestro Gaspare Mosca, divenivano un dramma organico. Il successo che arrise all’opera, fu veramente notevole e perdurò nel tempo al punto che, raccontano le cronache, ancora nel 1875, nella sola Palermo, se ne ebbero fino a trecento repliche. A favorirne la popolarità, che non si circoscrisse alla città di Palermo ma varcò i confini dell’isola trovando accoglienza nei teatri delle più importanti città italiane, contribuì l’interesse che, a livello di opinione pubblica, si andava manifestando per i fatti di mafia e per i mafiosi. La rappresentazione attirò fior di spettatori in tutto il Regno, fra i quali non mancò Umberto di Savoia, il principe ereditario, il quale poté assistere allo spettacolo in un teatro di Napoli. Il dramma portava per la prima volta in scena la mafia e il contesto nel quale si era sviluppata azzardando, nonostante un taglio alquanto infantile, qualche interpretazione di tipo sociologico dello stesso fenomeno criminale del quale, gli autori erano abbastanza informati avendo avuto notizie di prima mano sugli usi e sulle consuetudini della “Vicaria” di Palermo: Si erano infatti serviti delle confidenze di Gioacchino D’Angelo, un capo camorrista, così erano allora definiti gli uomini d’onore, che aveva trascorso qualche anno di reclusione nel tanto famoso che terrifico carcere palermitano chiuso nel 1842 dopo la costruzione dell’Ucciardone. Se il testo de “I mafiusi de la vicaria”, non dà un’idea approfondita di cosa fosse la “mafia”, offre, tuttavia, un profilo abbastanza puntuale di chi sia il mafioso come elemento criminale sfuggendo alla visione romantica che, fino ad allora, era molto diffusa. Il mafioso del dramma di Rizzotto è infatti un delinquente, sempre d’estrazione popolare, arrogante e volgare appartenente ad una consorteria criminale modellata su quella della camorra napoletana. Il dramma di Giuseppe Rizzotto, forse senza volerlo, realizzava anche un’operazione pedagogica, pioneristica per quel tempo. Esso, infatti, come ha scritto Giovanni Tessitore, aveva il pregio “di far nascere nello spettatore un sentimento di avversione per quel modo di vivere”. “I mafiusi de la vicaria”, al di là del valore dell’opera stessa – non rilevante dal punto di vista letterario – ha avuto dunque il merito di lacerare il velo di silenzio che avvolgeva il fenomeno mafioso e, soprattutto, di averlo smitizzato privandolo dell’aureola romantica che continuavano a gratificarlo. L’opera ha attratto l’attenzione dello stesso Leonardo Sciascia. Lo scrittore racalmutese rilesse l’opera e ne fece un libero adattamento nel 1966, non mancando di sottolinearne, soprattutto un aspetto – aggiunto da Rizzotto e Mosca nella seconda edizione – che fino ad allora era stato poco attenzionato. Parliamo del rapporto fra la mafia e la politica incarnato dal personaggio anonimo, definito “l’incognito”, che sembrerebbe corrispondere al profilo di Francesco Crispi, il quale spiega i suoi buoni uffici per consentire al protagonista, tale Gioacchino Funciazza di uscire dal carcere riguadagnando la libertà. Interessante poi, come ha rilevato lo storico Gaetano Falzone, è che “I mafiusi de la Vicaria” insinua, anche questa anticipatrice, un’intuizione. E cioè che l’abbinamento di “mafia e politica non è mai di alleanza contingente ma risiede nella natura dell’ambiente, dell’individuo, delle grandi e piccole cose che fanno la vita siciliana di ogni giorno.”